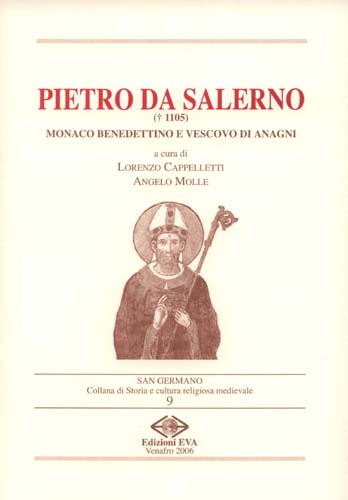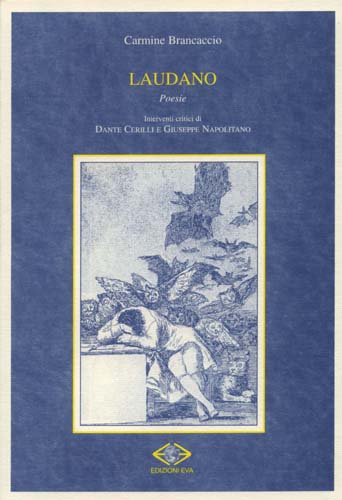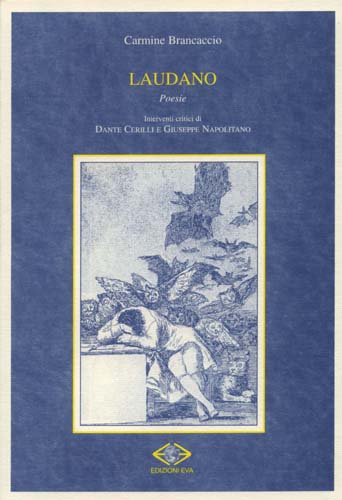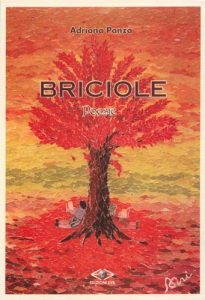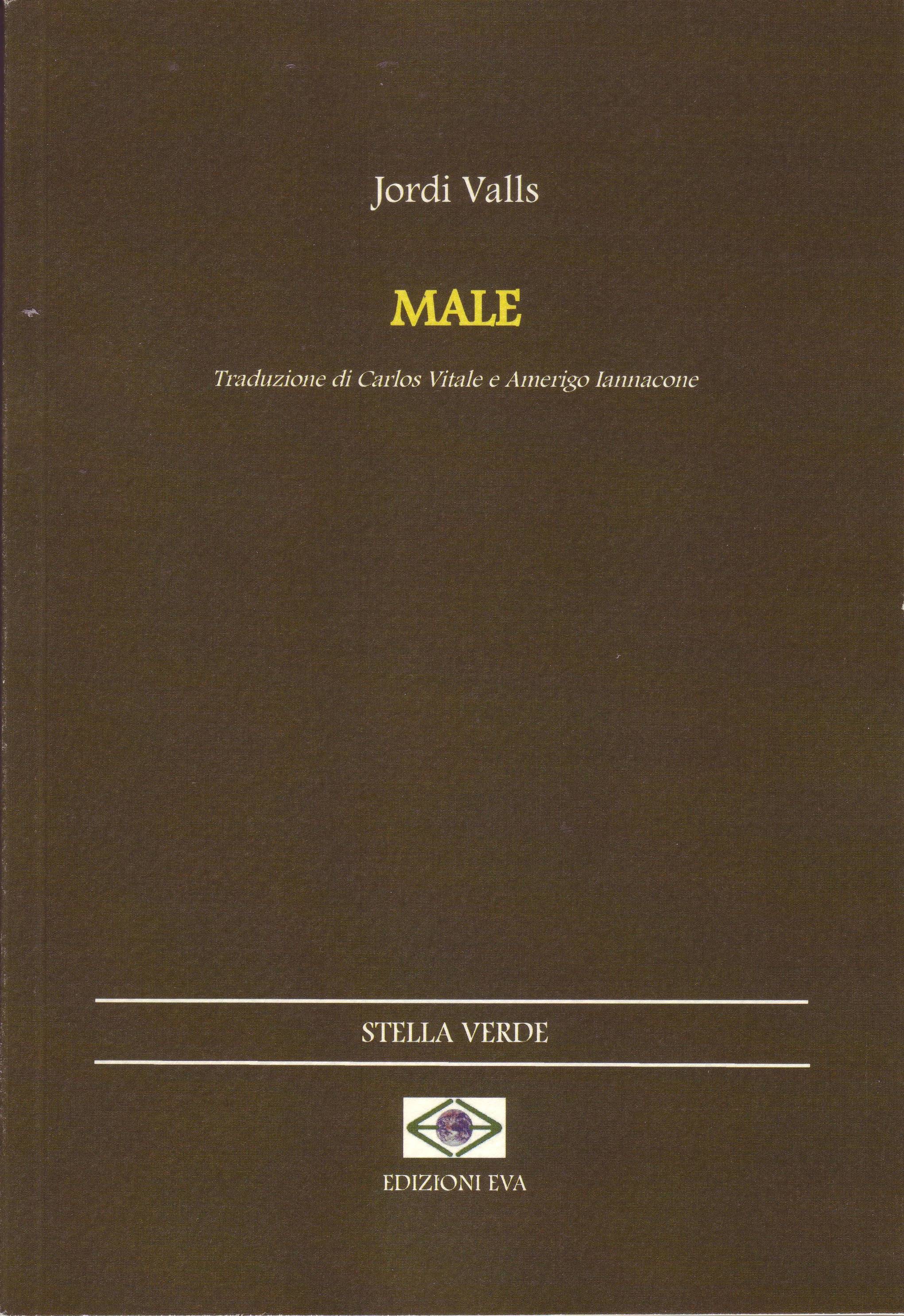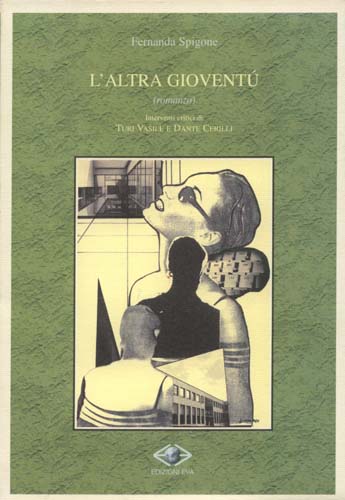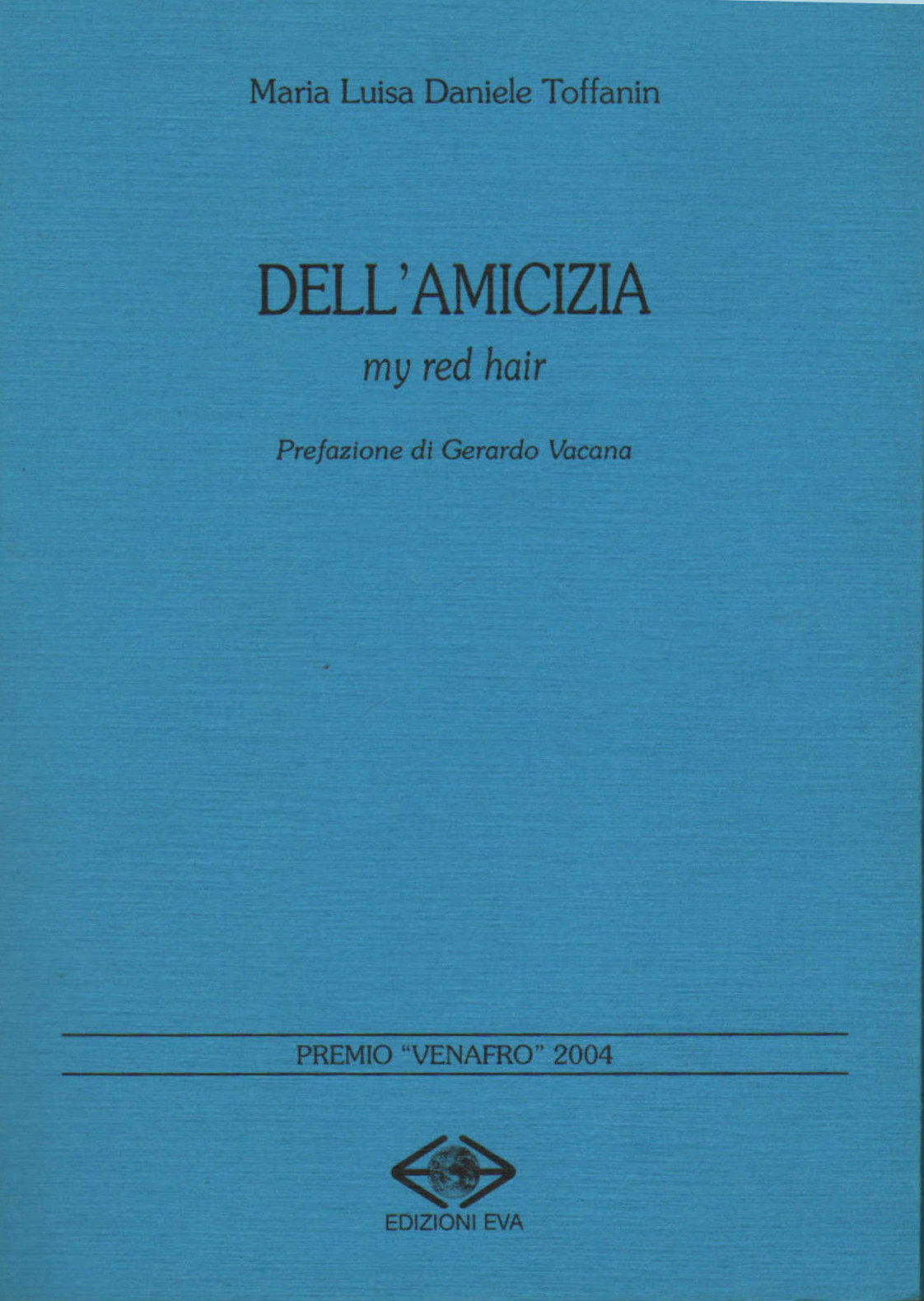- Titolo
|
Dell'amicizia - my red hair
|
- Autore
|
Maria Luisa Daniele Toffanin
|
- Collana
|
Premio "Venafro"
|
- Pagine
|
54
|
- Anno
|
2004
|
- Prezzo
|
€ 9,30
|
Anche il precedente libro della Daniele Toffanin, Per colli e cieli mia euganea terra, ha per protagonista un paesaggio con figure e il presente un’amica scomparsa, cui quel paesaggio fa da sfondo, c’è tra i due volumi una sostanziale continuità: l’uno e l’altro ispirati a un amore per la propria terra cos’ profondo da identificarsi con essa, la sua civiltà, i suoi abitanti, l’uno e l’altro animati da una visione positiva, etica, spirituale della vita, con una particolare tensione a cogliere il “magico arcano”, il sacro, l’invisibile. Alla coralità del primo libro succede qui la concentrazione in un personaggio, che l’autrice non nomina, ma rappresenta con una sineddoche, un connotato fisico che meglio la caratterizza: «la rossa criniera», presente nel sottotitolo, che di volta in volta, chiamata ad esprimere lo stato d’animo prevalente, diventa frizzante, radiosa, amorosa, pudica, danzante, incantata, operosa, lucente, euforica, anche smarrita, snervata, strappata, ma con forte prevalenza dei momenti positivi. Il nuovo libro è il poema dell’amicizia (giusta il titolo), la rievocazione a caldo, sull’onda ancora dell’emozione e del dolore, di uno straordinario personaggio, colto nei suoi momenti piè significativi di docente, di sposa, di madre, di amica, diversa e sempre identica nel suo carattere tenero e ardente, profondamente innamorata della vita. È un’amica con cui l’autrice ha vissuto in simbiosi per trent’anni, condividendone gioie, entusiasmi, speranze, ansie e delusioni, soprattutto per il rapido degradarsi di un costume e di una civiltà tra le piú umane e raffinate, come la veneta.
Il libro, diviso in due parti: “Il nostro tenero tempo” e Il nostro tempo maturo”, composte di cinque sezioni ciascuna, si annuncia sin dalla Praefatio come lo spartito di una composizione musicale, dove prevalgono note di gioia e di luce: «Evocate al bulino del dolore / dirò amica di ore nostre glissate / tra sabbia di clessidra / note lucenti d’amicizia / [...] emerse / vive per questo mio spartito / ché in ogni rigo di noi insieme / si sente il suono della gioia, / [...] e di chiari accordi d’acqua / dal mare dei tuoi gesti / dal profondo tuo inquisire / segni d’un nobile lavare / che ancora dà nitore / ai tuoi diletti spazi / al tuo sentire di cristallo.» (p. ).
Nella seconda lirica sottolinea fortemente, con la ripetizione del verbo lavare (tra le parole-chiave del libro), l’anelito dell’amica alla limpidezza, alla pulizia fisica e morale, già affermato nella Praefatio leitmotiv del volume, insieme all’«endemica sete di vero» (altrove «ansia del vero», «ricerca del vero»). Nella stessa composizione si canta «quel mite angolo agreste / dimora d’umana cultura», dove fiorí «raro il seme dell’amicizia / nel tempo diramata / in presenza una nell’altra». È il «bucolico spazio» della scuola immersa nella campagna euganea, con un’asina che poggiava il muso sul davanzale della finestra a pian terreno, «con gli allievi quasi amici / la mente vivace e chiari disegni». In questo profondo amore per la campagna, in questo vagheggiare o rimpiangere un’Arcadia perduta, che sono un patrimonio di ogni scrittore o artista veneto (si pensi anche a certe sculture di Arturo Martini), si avverte ancora fruttuosa l’eredità del Nievo, come in ogni figura femminile creata da quella letteratura fa capolino qualcosa della Pisana.
Ai giovani la docente «diceva l’urgenza / d’un vivere insieme cortese / alla voce di un’etica stella». Umanità, cortesia, eticità, sono i valori che accompagnano docenti, discenti e contesto sociale, a formare un’armonia, di cui è elemento attivo anche la natura. Si leggano, a questo proposito, le tre liriche della Leggenda agordina. «Mai ci fu ora d’amicizia / uguale tra noi e la natura», come in un’esperienza vissuta insieme con ragazzi ed amici, appunto, sulle Dolomiti agordine. La purificazione di ogni pensiero – preoccupazione costante delle due amiche – si realizza a contatto con l’innocenza delle cose, con la verità dei primordi (altra grande intuizione del libro), come nella «sfera d’armonia» che regna su quei monti.
Si torna spesso nel libro sull’intreccio del binomio gentilezza ed etica, passione (fuoco interiore) e dovere, poesia e sofia, a colorare piú intensamente il «tenero tempo» la prima, il «tempo maturo» la seconda. In un’opera caratterizzata da un lirismo nutrito di pensiero e dei eticità, non poteva mancare una sezione una sezione dedicata all’enigma della presenza del male, del «non giusto» nella vita di ognuno e nel mondo, ed è questa sezione a chiudere la prima parte del libro.
Nella seconda parte prevalgono interni e spazi e spazi urbani di Padova. E analogamente a quando accade per la campagna, c’è rimpianto sincero per la scomparsa di antichi costumi e di una certa patavinità, cosí cara alle due amiche: «lavava le vecchie botteghe / vivaci intarsi allora di vita / battito ora spento di patavinità / accendendo due tre parole / di melodiosa cadenza / là con la gente semplice / delle piazze sotto il salone. / [...] lavava vicoli angoli / spazi d’umbratili silenzi / lastricati d’ogni fattura / dissacrati con dismisura / la rossa criniera indignata / all’assenza d’urbano decoro / d’un tempo troppo arrogante.» (p. ).
Senza essere femminista, anzi puntando tutto sul recupero della grazia e della tenerezza, che sono caratteri insopprimibili della donna, questo libro è anche un inno all’energia femminile, che in India chiamano shakti, qui simboleggiata dalle «ali ai piedi», dall’«ebbrezza della danza» dell’amica. E si sa che la danza consente di esprimere non solo sentimenti ed emozioni, ma anche spiritualità, accostandoci all’anima delle cose per cogliere il senso del cosmo. «E lavava lavava / lavava le mani gentili / come mattinale catarsi / fugate al lucore le ombre / per nuova energia alle ore. / Metteva gli anelli suo vezzo / con rapido tocco al mantello / alla rossa criniera arresa / ai suoi calzari i piú alati». (p. ). Anche l’amicizia è intesa come movimento ed energia: «amicizia-slancio di campana / ch’esplode di suoni un mattino / e l’eco vive per sempre». E il rapporto con le cose è inteso come fatto vivo, attivo, reattivo: «E nell’armonia tra sé e le cose / rinnovava l’interiore percorso / nel sogno dei fiori / nell’ansia del vero / nell’urto con gli eventi / sempre vestale nel tempio / della parola ardente.» (p. ).
Il libro si chiude nel segno (alto) del Foscolo, già alluso nel ricordo delle «luminose vendemmie», nella vigna dello sposo e al tempo della festosa raccolta; ma soprattutto per la certezza che «al tepore del ricordo / lei mi rivivrà ogni momento / come in un’infinita primavera / colore-odore di quei grappoli / pegno-impegno d’amicizia / profumo benedetto ancora sempre / che vola alto oltre il vento / della brughiera d’inverno / e non si sperde.» (p. ).
Se tematicamente tra il precedente volume e il presente c’è affinità, sotto il profilo delle scelte di stile e di lingua la loro identità è totale. Anche in Dell’amicizia continua il rifiuto della poesia pura e dell’ermetismo, che con le loro costruzioni, rinunce, tagli, autocensure, hanno prodotto tante pagine «non si capisce ed esangui», per dirla con Quintiliano. Nessun pregiudizio, nell’autrice, ai danni dell’esplicito, del troppo detto, nessun freno alle espansioni, bensí un fidente, entusiastico abbandono alla piena degli affetti, ai voli arditi della fantasia agli slanci in avanti della speranza e dell’utopia. Ciò reclama uno spiegamento di mezzi espressivi abbondante, a tutto campo, che coinvolge le sostanze, le qualità e le azioni. Donde il plurilinguismo, la folta presenza di neologismi e di arcaismi, la contiguità di lessico alto e di piú basso profilo, le ridondanze, le ripetizioni, le parole composte anche di tre sostantivi, le invenzioni ardite che rompono tutti gli schemi e i vincoli logici del discorso. È un’opera che musicalmente e pittoricamente si affida alla ricchezza, alla varietà dei colori e dei toni, piú che alla sobrietà e alla nettezza del disegno e del segno. Il risultato di tanta libertà e di tanto azzardo è quello di un innegabile arricchimento espressivo e di un’invenzione poetica che traccia percorsi inconsueti, originali, nuovi.
8 aprile 2004
Gerardo Vacana