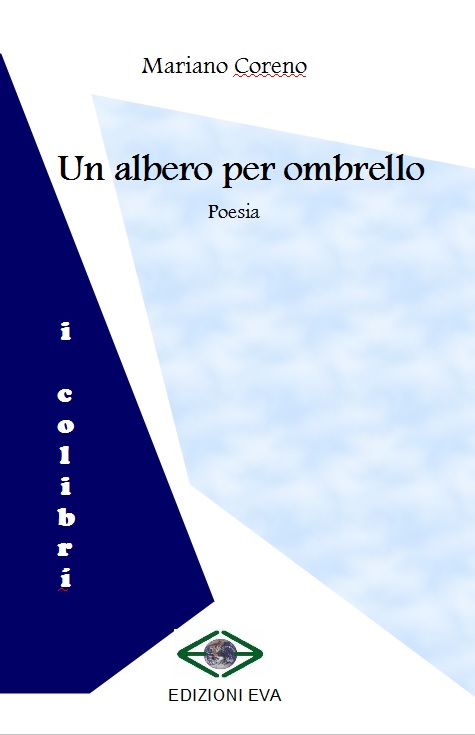- Autore
- Titolo
- Collana
- Pagine
- Anno
- Prezzo
|
|
Lina Rotunno |
|
|
La maestra Napolitano |
|
|
La stanza del poeta |
|
|
128 |
|
|
2015 |
|
|
€ 8,00 |
Invito alla lettura
Laggiù dov’è Mogador (tu cantavi) – e qui
ambasciatori di parola siamo insieme
come avresti voluto (perché basta
volersi bene – dicevi – a stare insieme)
Si fa maestra la rossa Marrakech
di umanità con l’augurio che si possa
volersi bene almeno fra poeti
– e poi
comunicare a chi ci ascolta un sentimento
di bontà (dedizione a chi ha bisogno
delle nostre parole regalate
a piene mani – maestra disponibile)
e di amore quello vero che non chiede
in cambio nulla – l’amore di una mamma
più che maestra per i suoi alunni.
Scritta a Marrakech, lo scorso aprile, in occasione della nostra partecipazione (io e Irene, insieme) al Festival internazionale di Poesia – invitati dall’amica Dalila Hiaoui –, questa riflessione lirica dedicata a mia madre era intenzionalmente preparata per aprire la pubblicazione delle sue pagine scelte, a cele-brazione dei cento anni dalla sua nascita.
Ho dedicato gran parte dello scorso 2014 a ricordare mio padre a cento anni dalla sua nascita – ora sento pure di dover fare almeno una cosa per la mamma. Già pubblicai, in due versioni, una scelta delle sue poesie (strappate a una decina di quaderni). Per questo centenario mi sono messo davanti le numerose agende in cui ha annotato quasi quotidianamente pensieri e sofferenze, e i diversi quaderni che usava per scrivere le sue pagine scolastiche.
Non le piacevano molto sussidiari e libri di lettura. che pur doveva far adottare ai suoi alunni di scuola elementare: preferiva scrivere personalmente i brani da far leggere e studiare... In particolare, a Natale o per la festa della mamma, il 2 o il 4 novembre, in tempo di carnevale o alla fine dell’anno scolastico, ogni occasione insomma era buona per comporre un suo brano e proporlo alla scolaresca.
Ho trascritto senza cambiare nulla. Tra parentesi quadre, alcune incertezze di costruzione, e qualche variante da lei stessa proposta. A posteriori, un po’ mi ha sorpreso, nelle pagine scolastiche, il frequente richiamo al Signore, certo ad uso di una pedagogia (quarant’anni fa, e più) rivolta comunque ad uno standard “ministeriale” che prevedeva – ideologie personali e convinzioni religiose a parte – che il maestro delle elementari impartisse anche i fondamenti della religione. Ma il Signore di mia madre abitava con lei, direi dentro di lei.
Insieme alle pagine di scuola, però, e a quelle più personali, di riflessione sulla propria natura e sulla vita in tempo di guerra, non ho resistito alla tentazione di proporre anche una – ridotta – scelta di poesie, fra le tante non pubblicate nei libri usciti a un anno e a dieci anni dalla morte: Strappi d’anima (Edizioni Eva, 1998) e Stracci d’anima (la stanza del poeta, 2007): completano, mi pare, il suo ritratto di maestra – perché sempre nella sua vita mia madre lo fu, operaia convinta in una grande fabbrica di uomini quale riteneva dovesse essere la scuola, ed anche fuori della scuola, poiché per lei un uomo degno di questo nome lo è nello spirito produttivo di bene per il prossimo.
Giuseppe napolitano
settembre 2015