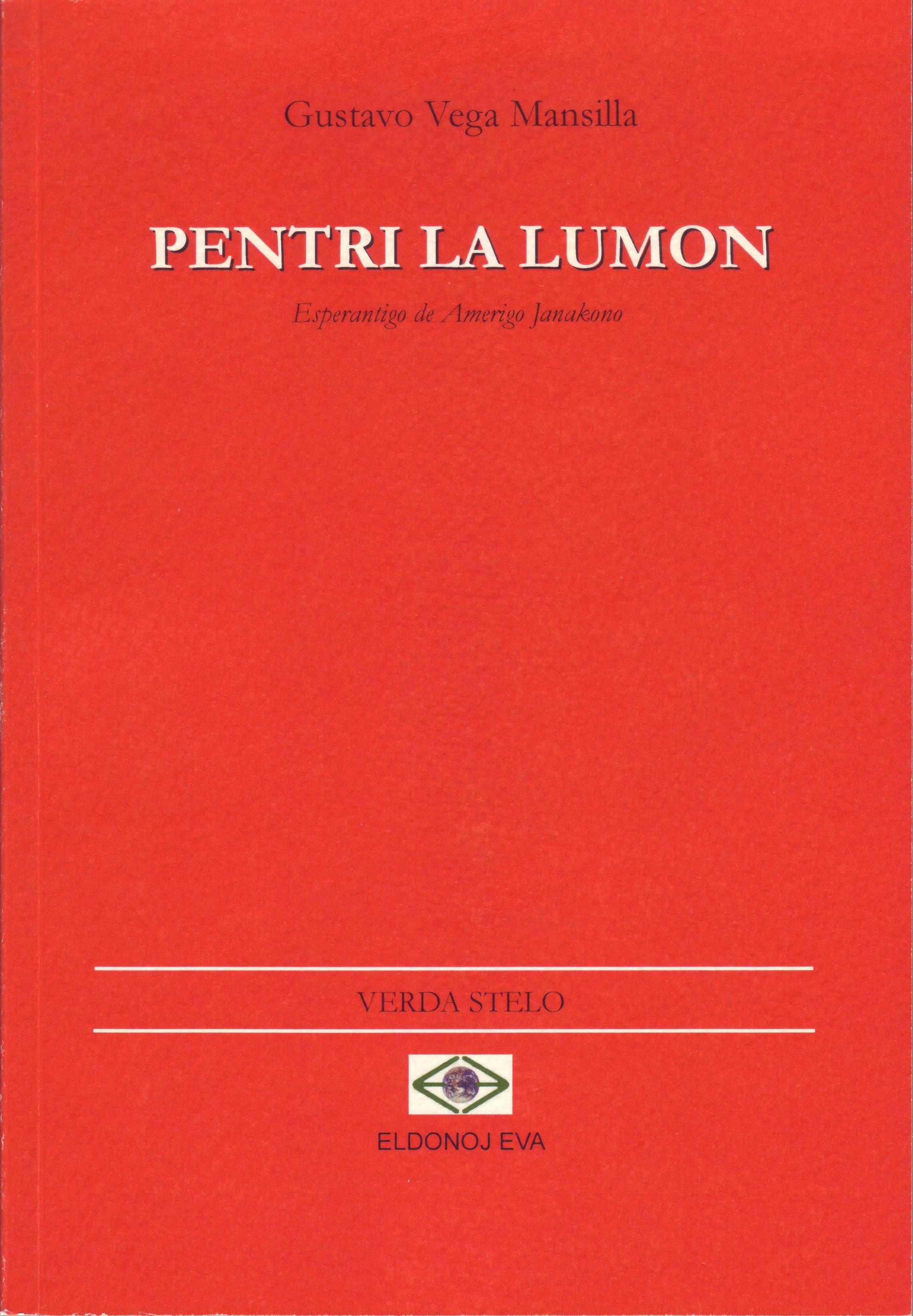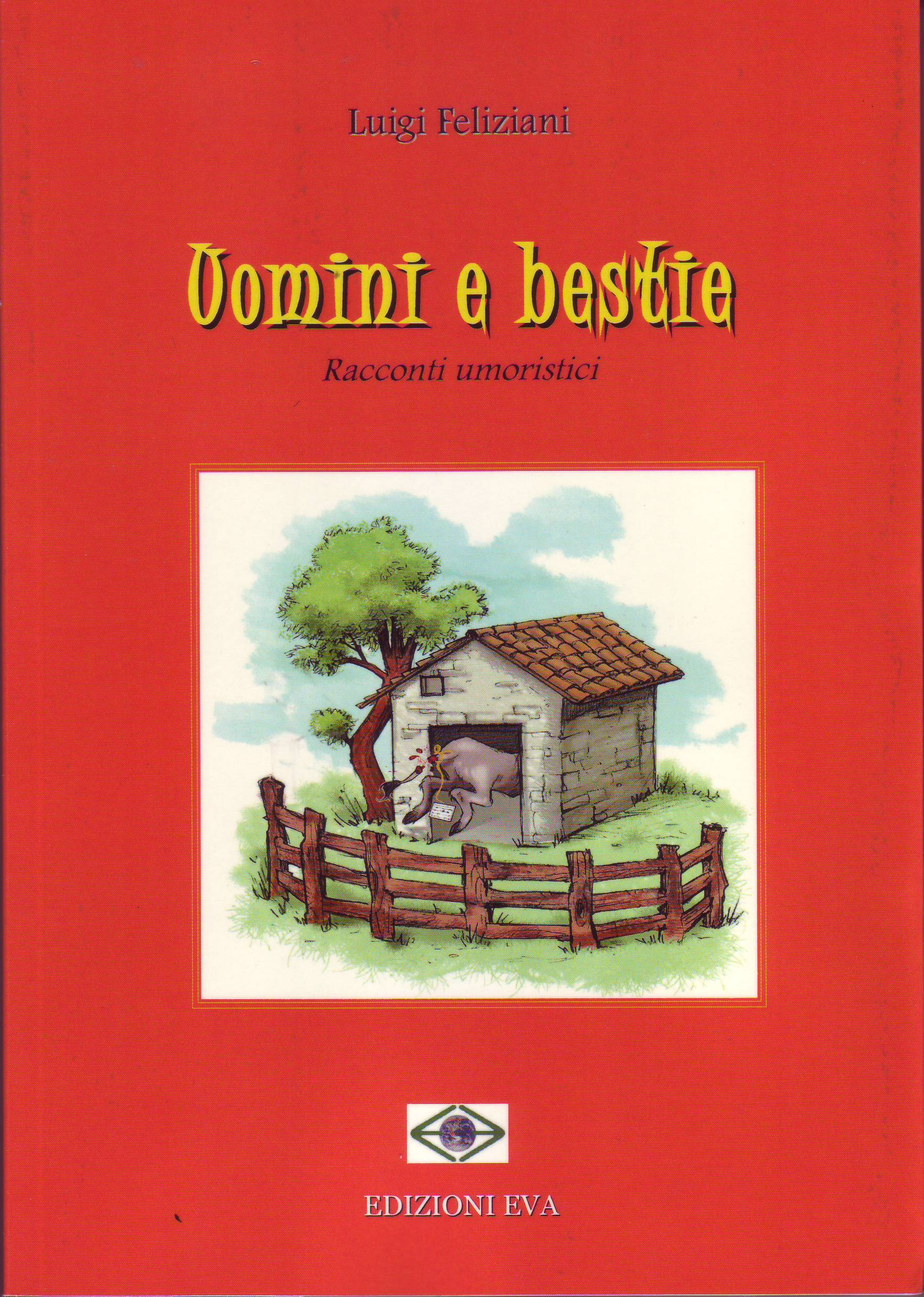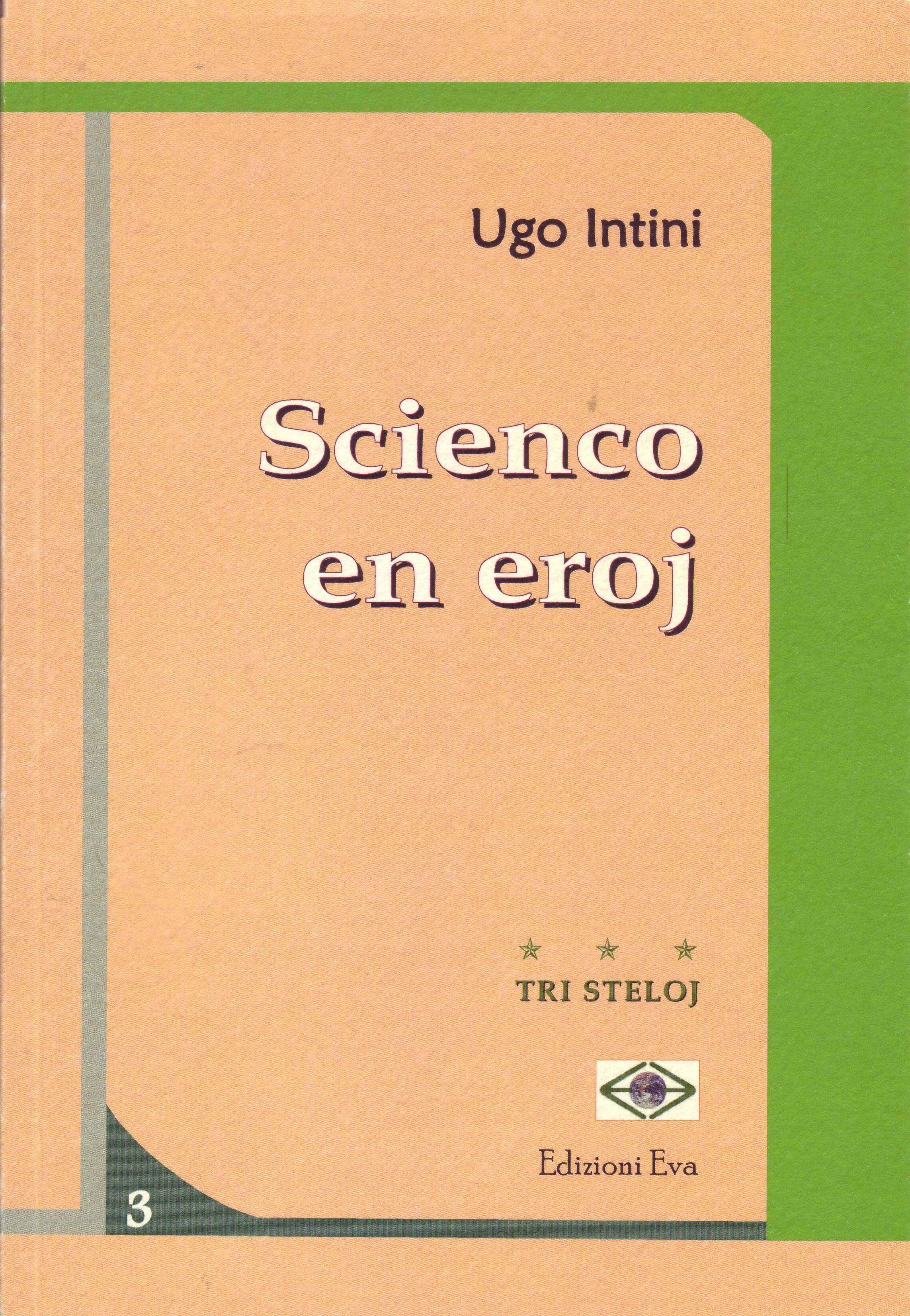Foglio Volante n°10 Anno XXXI Ottobre 2016
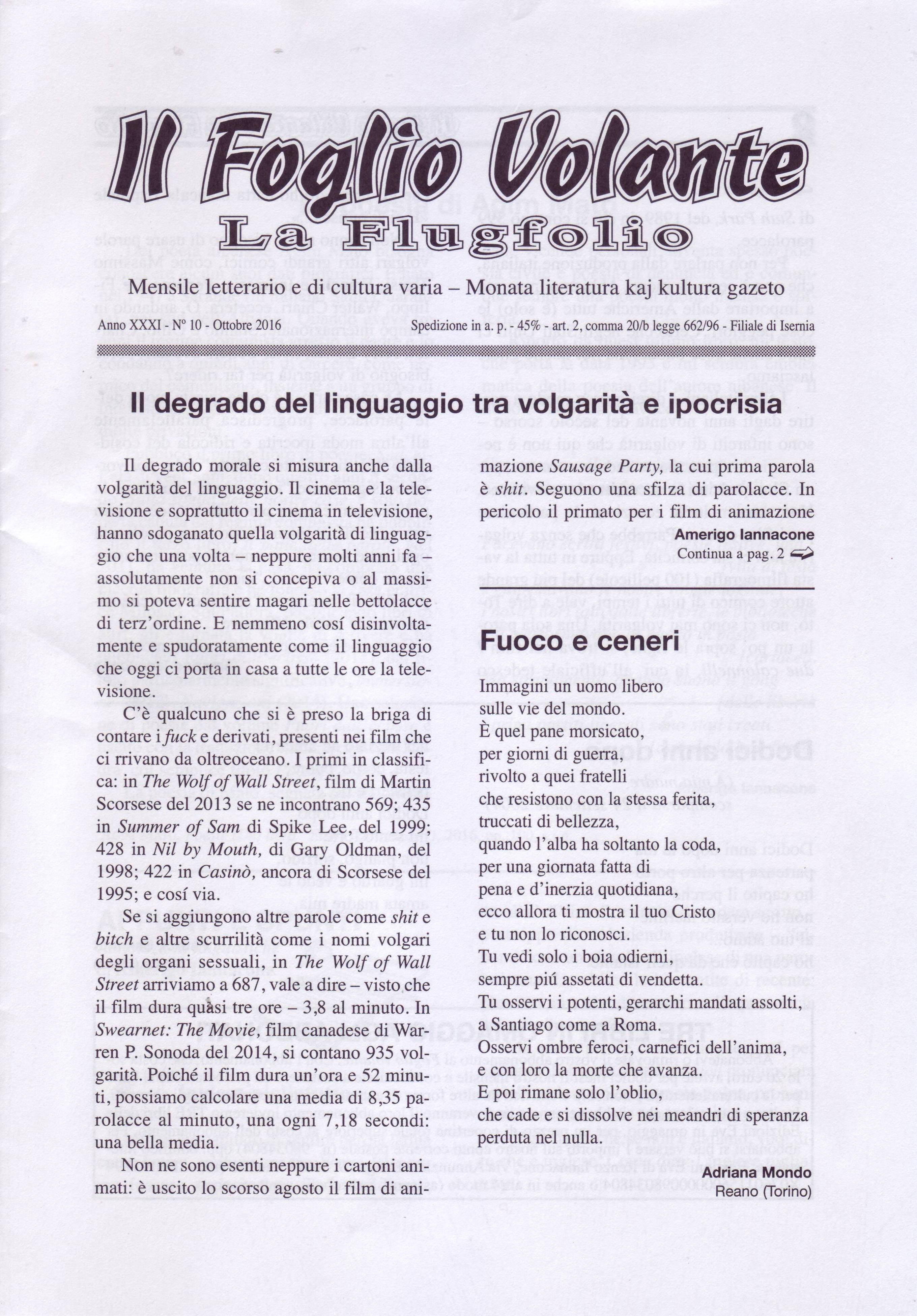
Il degrado del linguaggio tra volgarità e ipocrisia
Il degrado morale si misura anche dalla volgarità del linguaggio. Il cinema e la televisione e soprattutto il cinema in televisione, hanno sdoganato quella volgarità di linguaggio che una volta – neppure molti anni fa – assolutamente non si concepiva o al massimo si poteva sentire magari nelle bettolacce di terz’ordine. E nemmeno cosí disinvoltamente e spudoratamente come il linguaggio che oggi ci porta in casa a tutte le ore la televisione.
C’è qualcuno che si è preso la briga di contare i fuck e derivati, presenti nei film che ci arrivano da oltreoceano. I primi in classifica: in The Wolf of Wall Street, film di Martin Scorsese del 2013 se ne incontrano 569; 435 in Summer of Sam di Spike Lee, del 1999; 428 in Nil by Mouth, di Gary Oldman, del 1998; 422 in Casinò, ancora di Scorsese del 1995; e cosí via.
Se si aggiungono altre parole come shit e bitch e altre scurrilità come i nomi volgari degli organi sessuali, in The Wolf of Wall Street arriviamo a 687, vale a dire – visto che il film dura quasi tre ore – 3,8 al minuto. In Swearnet: The Movie, film canadese di Warren P. Sonoda del 2014, si contano 935 volgarità. Poiché il film dura un’ora e 52 minuti, possiamo calcolare una media di 8,35 parolacce al minuto, una ogni 7,18 secondi: una bella media.
Non ne sono esenti neppure i cartoni animati: è uscito lo scorso agosto il film di animazione Sausage Party, la cui prima parola è shit. Seguono una sfilza di parolacce. In pericolo il primato per i film di animazione di Suth Park, del 1989, in cui si contano 399 parolacce.
Per non parlare dalla produzione italiana, che non è certo da meno. Abbiamo imparato a importare dalle Americhe tutte (e solo) le cose peggiori. Certo che negli Stati Uniti ci sono anche cose buone, ma noi quelle gliele lasciamo.
I film italiani – direi grosso modo a partire dagli anni novanta del secolo scorso – sono infarciti di volgarità che qui non è necessario le ripeta: basta andare a cinema, per un film qualsiasi, o accendere la televisione. Non sono molte le eccezioni. In particolare per i film comici. Parrebbe che senza volgarità non ci sia comicità. Eppure in tutta la vasta filmografia (100 pellicole) del piú grande attore comico di tutti i tempi, vale a dire Totò, non ci sono mai volgarità. Una sola parola un po’ sopra le righe, si trova nel film I due colonnelli, in cui, all’ufficiale tedesco che gli urla: «Io ho carta bianche!» risponde «E ci si pulisca...».
Non hanno avuto bisogno di usare parole volgari altri grandi comici, come Massimo Troisi, Franchi e Ingrassia, Peppino De Filippo, Walter Chiari, eccetera. O, andando in campo internazionale, Stanlio e Ollio. Charlot, Jerry Lewis, Peter Sellers avevano forse bisogno di volgarità per far ridere?
La cosa curiosa è come questa moda delle parolacce, progredisca parallelamente all’altra moda ipocrita e ridicola del cosiddetto “politicamente corretto” (che poi vorrebbe significare “eticamente” corretto: la politica non c’entra per nulla). Cioè si può usare, come abbiamo visto, una parolaccia ogni sette secondi, ma non si possono usare parole come “sordo”, “cieco” e nemmeno si può dire di un alunno “respinto”, perché sono ritenute parole offensive.
Certo che è strano questo nostro mondo!
Amerigo Iannacone
Nancy
Nancy, la mia gattina
(la notte dorme al piano
sotto di noi, che siamo
un po’ la sua famiglia)
aspetta ogni mattina
che io scenda per farla uscire.
Se non muore lei prima,
un giorno non mi vedrà
piú scendere. Ma non smetterà
per questo di ritenermi
– tale e quale
ritiene se stessa – immortale.
Coreno Ausonio, 19/07/2016
Tommaso Lisi
Appunti e spunti
Annotazioni linguistiche
di Amerigo Iannacone
Inglese pigliatutto
Mi era già capitato di sentire parole latine come junior, medium, media, Venus, lette come fossero inglesi: “giunior”, “midium”, “midia”, “Vines”, e anche di vedere scritto – purtroppo da un’azienda produttrice – “albums” con un plurale all’inglese di una parola latina. Le ultime le ho sentite di recente: plus e minus che diventano nella pronuncia “plas” e “mainus”.
Ma anche parole di altre lingue, cosí, per esempio, la parola tedesca Reich pronunciata “reic’”, o la parola spagnola golpe, pronunciata senza la vocale finale, come fossero parole inglesi, perché se non è italiano, vuol dire che è inglese. Come dire : l’inglese pigliatutto.