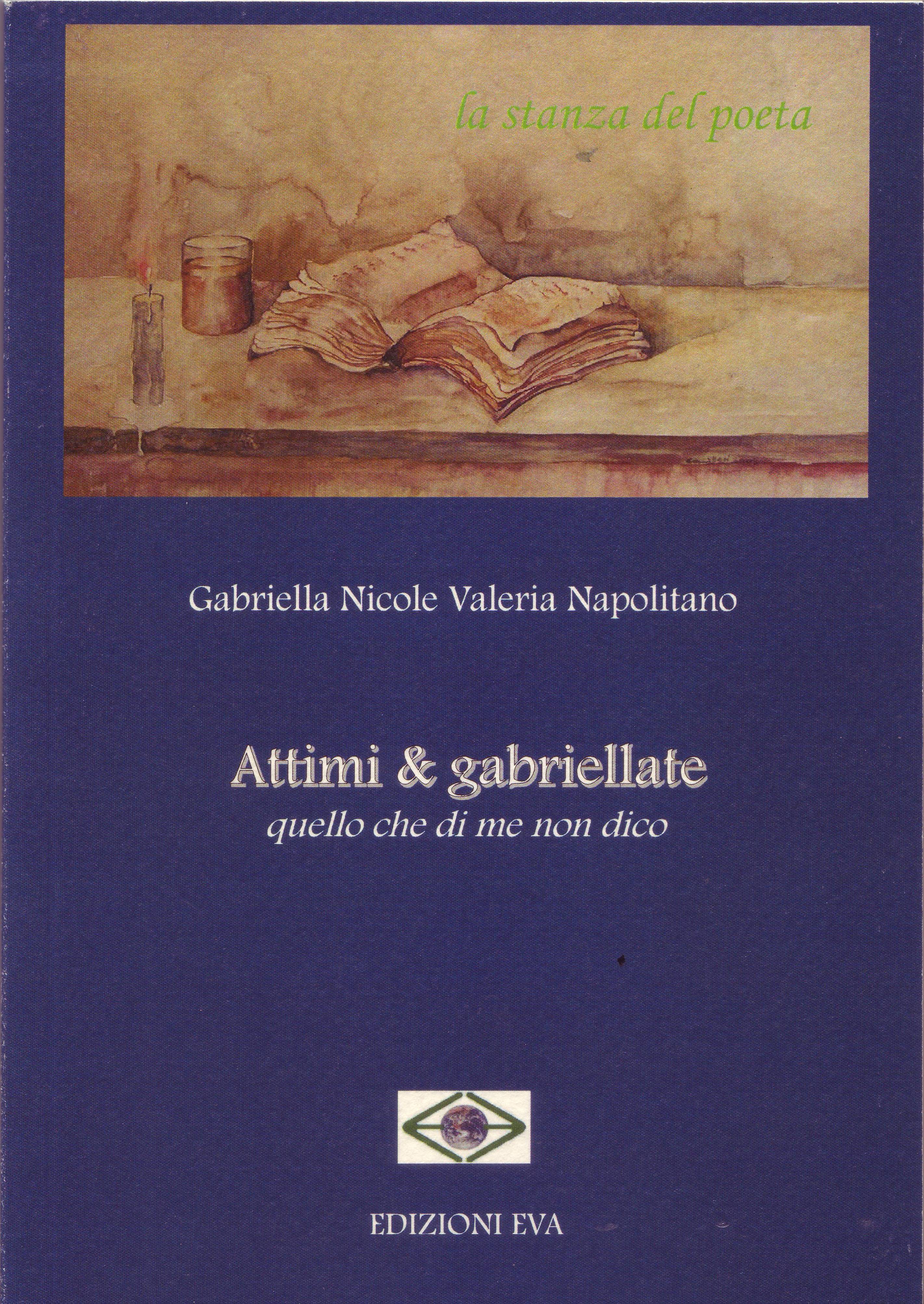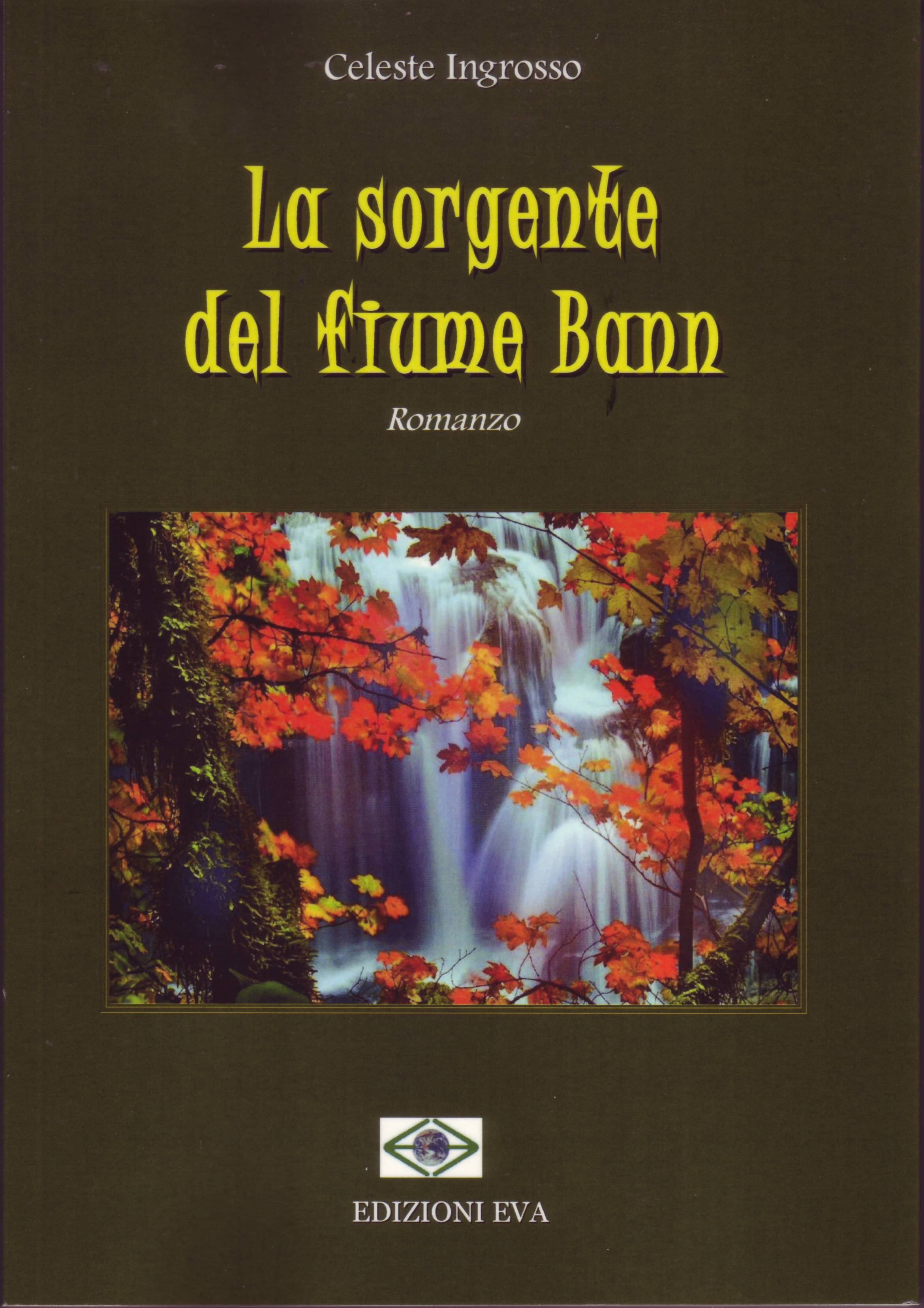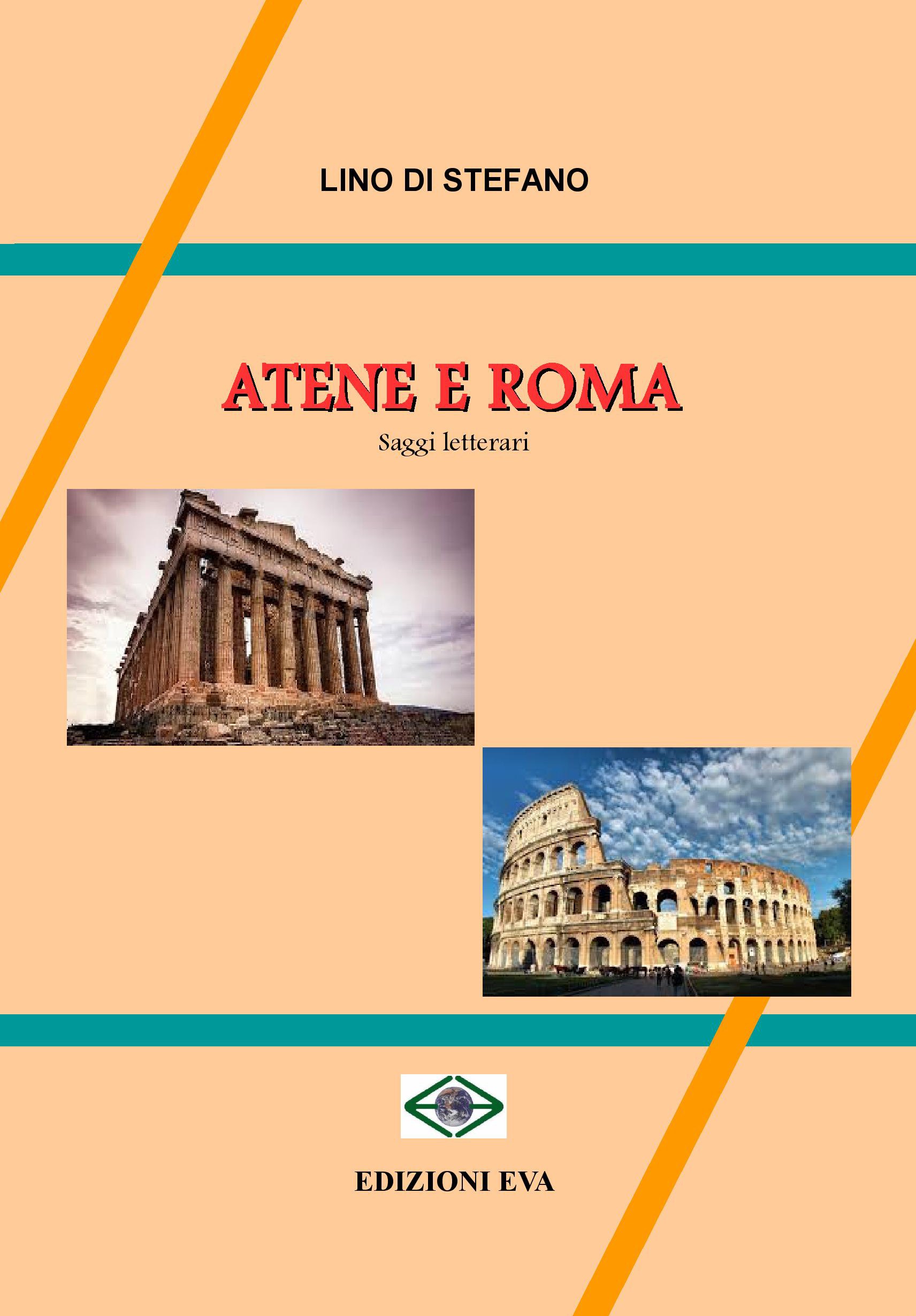- Titolo
- Autori
- Collana
- Pagine
- Anno
- Prezzo
|
|
Tra i vicoli della mia infanzia |
|
|
Gelsomino Marconicchio, Annamaria Marconicchio |
|
|
Perseidi |
|
|
136 |
|
|
2016 |
|
|
€ 14,00 |
Prologo
Stasera, ho trovato alcune vecchie foto in bianco e nero un po’ sbiadite. Le sfogliavo e mi ha preso un po’ di malinconia. Immagini dei miei genitori, sorelle, nonni e con loro c’ero io, un bimbetto di appena tre anni. Sullo sfondo di ognuna, i paesaggi di Frosolone, mio paese natio, tutti dello stesso anonimo color seppia. Dov’erano finiti gli splendidi colori sempre vivi nei miei ricordi? Ma a quei tempi non c’erano le fotografie a colori.
«Accidenti!» mi sono detto «Ma quanto tempo è passato?»
Ho iniziato a pensare a tutto quanto, negli anni, è accaduto intorno a me e a come me lo sono lasciato quasi scivolare addosso. Sembrava che ogni cosa fosse dovuta o senza particolare rilevanza. Ho visto il cinema passare dal bianco e nero al colore, poi le prime riprese in CinemaScope. C’ero, quando la carta igienica smise di diventare un lusso per pochi. Ho iniziato ad utilizzare olio imbottigliato e pomodori in scatola, senza neppure rendermi conto della novità. Ho permesso alla tecnologia di entrare in casa mia, con la televisione, la lavatrice e il telefono. Ho assistito all’uomo che andava sulla luna e alla caduta del muro di Berlino. Ho vissuto i drammatici anni settanta. Oggi ho il mio smartphone e il mio computer e non posso fare a meno di Internet.
Ho lasciato le fotografie sul tavolo; mi sono alzato, cercando inconsciamente uno specchio.
«Ma quanti anni ho?» mi sono chiesto, guardando la mia immagine riflessa «Che sia invecchiato senza accorgermene e senza mai diventare adulto?»
Non so perché, in quel momento mi ha sopraffatto il pensiero del piccolo Alessandro, mio adorato nipotino, e della mia scelta di non avere figli. Eppure i bambini mi piacciono un mondo, e adoro giocare con loro e coprirli di coccole; ma a me è mancato il coraggio di caricarmi della responsabilità di avere un figlio mio. Mi sono chiesto cosa avesse condizionato la mia decisione. Forse il ricordo della mia infanzia che ha formato il mio carattere, portandomi a prendere decisioni in maniera autonoma, mentre magari andrebbero condivise con mia moglie, o solo la paura di non riuscire a dare a mio figlio tutte quelle cose che a me sono mancate.
Mi sono avvicinato alla finestra e ho guardato fuori. È tardi e i negozi stanno chiudendo, la strada brulica di luci e di ombre, la gente si affretta per tornare a casa. Mi viene naturale pensare a quanto io sia stato fortunato ad essere nato in un bel paese di montagna. Come dal nulla, esplodono i ricordi.
Il mio paese… Frosolone sorge ai piedi del monte Gonfalone, su un’altura che domina interamente il basso Molise. La posizione elevata, circa 900 metri sul livello del mare, regala estati ed inverni fantastici. In estate non si viene oppressi dal caldo. Il cielo è di un azzurro profondo, che si fonde naturalmente con i colori della vicina montagna. Di sera si accende del luccichio di milioni di stelle, offrendo uno spettacolo mozzafiato. In inverno, è la neve a farla da padrona, offrendo panorami incantevoli.
Ricordo le rondini che a primavera tornavano numerose, rallegrando, con i loro voli, le vie del paese, mentre in montagna, i prati si coprivano di un vivace, unico, grande manto fiorito.
Agli inizi degli anni cinquanta, l’intera popolazione contava appena 5500 abitanti. In paese, ci si conosceva tutti; il divario economico tra le famiglie era contenuto, se si escludevano pochi benestanti. Gli abitanti erano gente mite e laboriosa e la semplicità della vita non offriva terreno fertile alla delinquenza che risultava inesistente. Vivevamo alla giornata! La cultura del buon vicinato era molto sentita e, dal momento che di danaro ne circolava ben poco, regnava in paese un forte senso di fratellanza, basato su condivisione e solidarietà. Vi era ancora qualche famiglia con retaggi nobiliari ai cui appartenenti era riconosciuto il titolo di don per gli uomini e di donna per le signore, appellativi che precedevano i nomi di battesimo. Era invece una piccola minoranza quella che ancora usava dare dei voi ai proprio genitori in senso di rispetto. In famiglia si usavano alcuni termini dialettali che erano particolarmente simpatici, come tate che significava padre, mentre nonno si diceva tatille e nonna tatèlla
La sera, appena dopo cena, i vicoli si animavano di allegria conviviale. Le donne che lavoravano all’uncinetto o sferruzzavano sull’uscio di casa, aiutandosi talvolta tra loro a srotolare le matasse di lana, quasi tutte indossavano delle caratteristiche mantelline di lana lavorate ai ferri per proteggersi dalle correnti d’aria che non mancavano mai in quei vicoli nelle ore serali. Gli anziani, seduti sui gradini delle loro abitazioni, sembrava aspettassero il tempo, mentre osservavano quanto accadeva intorno e raccontavano storie di tempi andati, della loro giovinezza. I ragazzini non erano mai stanchi di correre in giro, animando le serate con grida festose.
C’erano cosí tanti quartieri e borgate che, ad elencarne tutti i nomi, sembrava di essere in una grande metropoli. Alcuni prendevano il nome dalla famiglia che vi abitava, altri avevano riferimenti storici. C’era ad esempio un quartiere chiamato “L’Ospedale”, con riferimento ad un vecchio lazzaretto, presente in quella zona tanti anni prima, mentre nessun ospedale, cosí come lo intendiamo noi oggi, aveva mai occupato quel luogo.
Il paese si divideva in base alle tre parrocchie di riferimento di ciascun quartiere: Sant’Angelo, probabilmente la piú antica, San Pietro e Santa Maria.
Una caratteristica particolare del paese erano i soprannomi. Quasi ogni famiglia aveva il suo e alcuni erano alquanto bizzarri. La mia famiglia non ne aveva, forse perché la famiglia di mio padre era di origine termolese. I miei nonni paterni erano conosciuti semplicemente come Mast’ Peppine e Mariuccia La Furnara. La famiglia di mia madre, i Piscitelli, erano piuttosto numerosi e quasi tutti imparentati fra loro.