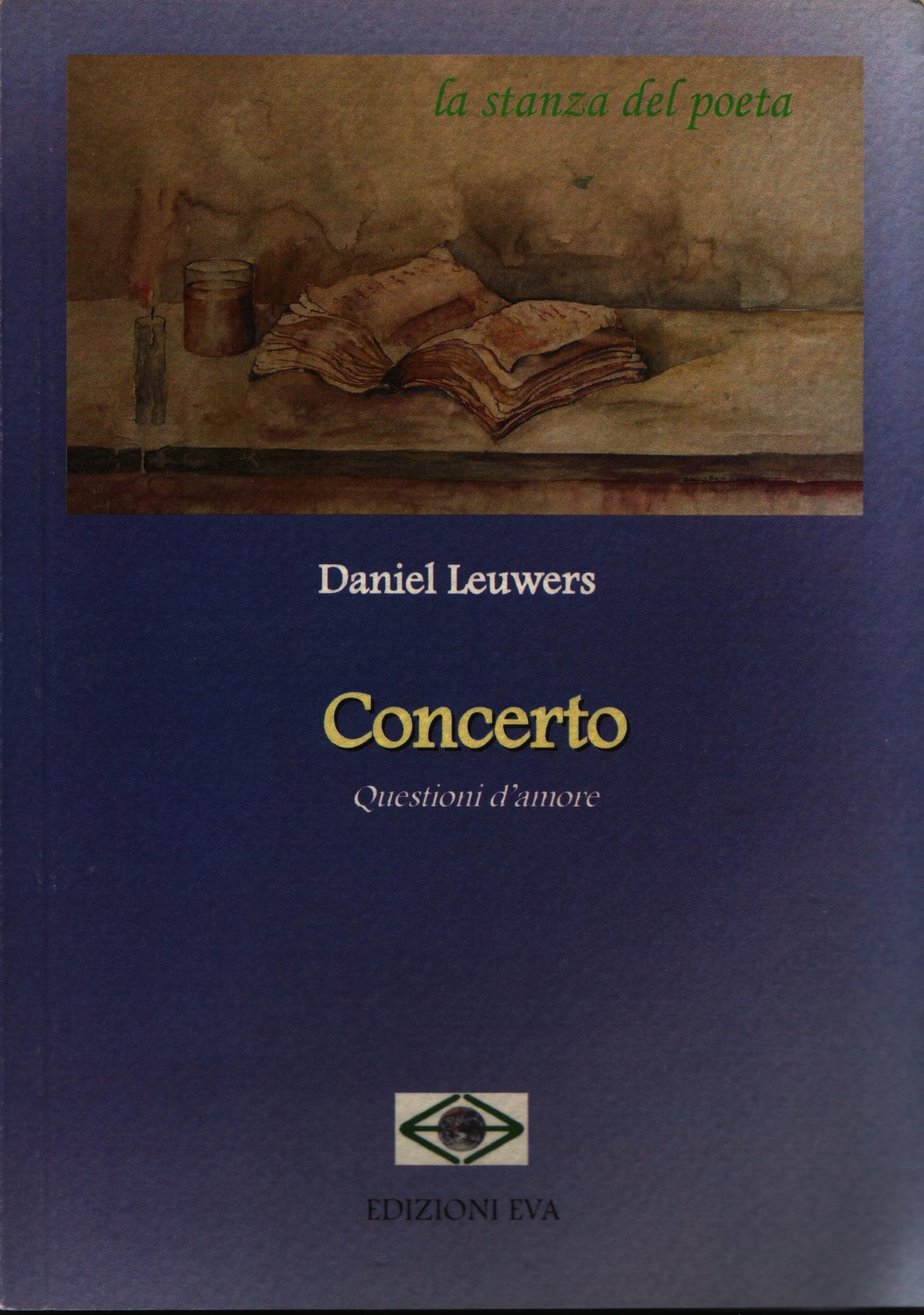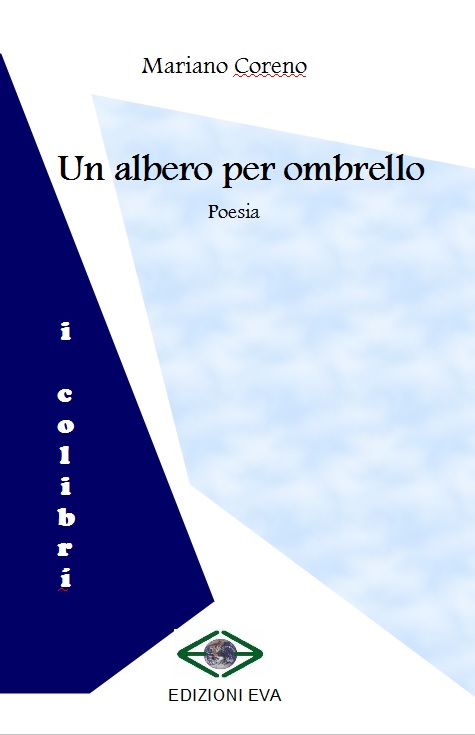- Titolo
|
La neve e il mandarino
|
- Autore
|
Alessandrina De Rubeis
|
- Collana
|
L'Albatro
|
- Pagine
|
120
|
- Anno
|
2015
|
- Prezzo
|
€ 12,00
|
Non solo poesia, anche memoria e storia
Questa seconda raccolta di poesie di Alessandrina De Rubeis è la naturale continuazione o, meglio, il naturale completamento della prima, La città nel cuore (2009), con cui forma un’autobiografia in versi, che ha come sfondo e cornice una grande città, Palermo, con il suo mare, la prima; il paese natale, San Donato Val di Comino, con la sua montagna, la seconda. I due volumi hanno una notevole ricchezza e varietà tematica e un arco temporale, che copre anche l’età matura dell’autrice fino ad oggi, ma centrale in entrambi è il motivo dell’infanzia e dell’età scolare in genere, trascorsa parte a San Donato, parte a Palermo.
Il trasferimento dal paese avviene sempre in modo inatteso, e anche se in Sicilia va a vivere prima con i nonni materni e poi con gli zii, tutti molto affettuosi, la bambina inevitabilmente ne risente e ne soffre; ma la capacità di adattamento propria dell’età e il carattere vivo, ricettivo, avido di conoscenza di Alessandrina le fanno superare i disagi dei vari trasferimenti. I lunghi soggiorni nell’isola prima del definitivo ritorno a San Donato – per frequentare poi a Sora le Magistrali con ottimi docenti – consentono alle radici del suo ramo materno di attingere in loco nutrimenti anch’essi preziosi, insostituibili per la formazione del carattere e per la futura creatività poetica.
Il paese, le favolose vicende dell’infanzia sono viste, rivissute con gli occhi di quando era bambina. «Ti guardo / e ti rivedo bello come allora / quando fuoriuscivo dalla neve / solo di poco e mi sentivo lieve»: sono i versi della prima poesia, Piccolo paese, dedicata appunto al paese natale, che vive intatto nella memoria.
Questa prima composizione non solo contiene i temi principali, ma ci dà anche l’atmosfera, il tono dell’intero volume. C’è la descrizione di San Donato con l’antica torre, le case mura, le case a grappolo raccolte, le scale che si arrampicano verso l’alto, c’è l’Appennino che lo protegge alle spalle ma anche lo scuote con i terremoti, c’è la neve, c’è il miracoloso aspetto urbanistico che lo fa apparire un triangolo perfetto, frutto della maestria della sapienza antica, cioè dei maestri muratori e degli altri artigiani – scalpellini, fabbri, falegnami, pittori –, di cui l’autrice, nipote e figlia di artigiani, è giustamente fiera. C’è, nell’ultima strofa, un fulmineo trapasso, una identificazione tra il paese e l’infanzia, molto indicativi anche dello stile dell’autrice, che volentieri fa ricorso al-l’analogia: «Piccolo paese / profumo di legno e di pietra / infanzia di muschio e parietaria.»
La prima lirica ci offre un’altra indicazione, che è forse la sua piú alta: il paese natale, nell’evocazione poetica, è sempre circonfuso da un’aura sacra, da un’at-mosfera naturaliter religiosa, che è una prova di come il sacro, che in questo caso possiamo identificare col sentimento religioso, non sia una sovrastruttura ma una componente essenziale, insopprimibile della mente e del cuore dell’uomo, sin dalla piú tenera età; e questa rac-colta di Alessandrina è anche un mirabile documento poetico di tale fondamentale verità. Nel testo, il piccolo paese è un santuario, un tenero presepe, che nei terre-moti «piú sicuramente confida / nel santo nome che si è donato.»
Nelle liriche che seguono assistiamo allo svolgersi dei giorni in una perfetta armonia tra i bambini e la natura con i suoi elementi, come detto in Compagni di allegria: «Giocavamo a nascondino / nel borgo degli antichi te-sori / tutt’uno con noi / quando scoprivamo la tana.// All’aperto anche con le intemperie, / il solo rischio in quei tempi tranquilli, / ma sempre la neve la pioggia il vento, / si trasformavano in compagni di allegria.»
Vengono poi i mesi da maggio a dicembre e a gen-naio (con la befana), ognuno caratterizzato da un evento particolarmente significativo per la vita del paese e dei suoi abitanti, piccoli e grandi. Le feste religiose ricordate, prima del Natale, sono quelle del 13 giugno, dedicata a Sant’Antonio, e del 7 agosto, in onore del Patrono San Donato. Ammirevole la delicatezza da acquerello con cui viene rievocata la prima, con i gigli bianchi correlativo oggettivo del pudore dell’età infantile, e con i ragazzini che a sorpresa spuntano dai supportici, e allora un timido sorriso appena accennato tinge di gioia innocente le guance delle bambine. Tutto acceso dai fulgori del mattino estivo, dal manto rosso dell’imponente Patrono, dall’immancabile cocomero anch’esso rosso sulla tavola imbandita a festa, è invece il quadro ispirato alla festa di San Donato. Ut pictura poesis è il caso di dire con Orazio. Aggiungerei alla poesia e alla pittura anche la musica, presente con le campane in festa, i canti dei pellegrini, la banda, e, perché no, i vicoli plaudenti al passaggio della processione e i fuochi d’artificio. Quasi una spontanea concertazione delle tre arti.
Il lavoro delle donne e quello dei campi sono an-ch’essi onorati da Alessandrina: «Sedute davanti casa, le donne / intessevano ricami e storie, belle nell’antico co-stume e con un sorriso ricco di saggezza sul volto.»
L’asinello torna ad essere protagonista in questa civiltà non meno contadina che artigianale, come lo era l’indimenticabile ciuchino da Un amico vero in La città nel cuore: «Il rientro dell’asinello, / carico del raccolto e di fascine, / dava il segnale della cena / e subito i rin-tocchi / della campana dell’Ave Maria.» Sembra un quadro di Jean-François Millet, il pittore dei contadini francesi. L’asino è il compagno di lavoro paziente e pre-zioso, che noi lettori anziani abbiamo avuto la gioia di conoscere e di amare.
Siamo grati ad Alessandrina di averlo ricordato come merita anche in questa raccolta. Leggiamo infatti in Settembre: «Dolce settembre di vacanze allegre, / che ci svegliavi di buon mattino, / l’asino preparato con la soma / e due grossi cesti ai fianchi, / io e Raniero ci ca-lavamo dentro, / la zia, a piedi, manteneva la cavezza.» E in Gallinaro ricorda Salomè, l’asino delle zie, che ac-compagnava il padre nelle trasferte nel paese vicino, per fare provviste di sale, farina, uova e ortaggi. Quest’asino con tanto di nome mi ricorda l’asino Gabriele di nonna Gerarda, che alloggiava proprio sotto la stanza in cui sono nato, e i tanti asini che per oltre cento anni hanno fatto la spola, coi loro padroni sempre a piedi, tra Gallinaro e i centri del contiguo Abruzzo, Opi, Pescasseroli fino a Scanno, per fornire quei piú freddi paesi di vino, olio e frutta di ogni genere, riportando nella nostra valle saporiti formaggi e legna di bosco da ardere.
Siamo ormai nell’autunno inoltrato e, presto, in pieno inverno, Come potevano mancare i carbonai e gli zampognari? I primi «Scendevano dai monti ch’era autunno, / sulle spalle mantelli e sacchi neri», e fornivano il carbone per cucinare e soprattutto per fare il pane di casa: «Aveva un buon sapore / il pane di casa, / sapeva di forno a legna / e di donne affaccendate / che custodivano / nella madia la farina, / bianca come il grembiule / alla cintola annodato / e come il fazzoletto sui capelli, / bianco come la tavola apparecchiata / e con intorno tante sedie.»
Se nel primo libro il colore prevalente era l’azzurro del mare e del cielo, anche se solo sottinteso e tuttavia fortemente avvertito come tale, qui è il bianco della neve (quanta neve!), della farina, della tovaglia sulla tavola apparecchiata, dei capi dell’abbigliamento paesano; e mi viene spontaneo vedere in tanto bianco anche il simbolo del pudore e della santità di queste madri e sorelle sempre in faccende, per tenere in ordine la casa e unita la numerosa famiglia (vedi le tante sedie intorno al tavolo con una precisa “citazione” da Libero De Libero).
Gli zampognari annunciavano il Natale imminente e ne creavano l’atmosfera: «Erano due gli zampognari […] Venivano da un paese non lontano / [ Villa Latina] a portare in ogni casa la novena.» Rimanevano nel paese nove giorni, ospitati generosamente ma alla buona dalle due zie. Nel loro canto e nel suono del piffero e della zampogna, descritti nel romanzo La ragazza perduta, D. H. Lawrence, ospite a Picinisco con la moglie Frieda nel dicembre del 1919, sentiva la voce stessa delle nostre montagne.
Natale significava anche il presepe, immancabile in ogni casa ancora oggi. È una tradizione particolarmente sentita a San Donato, dove fino a qualche decennio fa, gli artigiani di ogni rione, con l’aiuto dei giovani, ne costruivano di bellissimi e di notevole valore artistico, per un concorso a livello regionale e non solo.
Alessandrina, sensibile al dolore e alle disuguaglianze del mondo contemporaneo, vede un presepe davvero vivente nella metro di Milano: un bimbo e una madre di nuovo gravida, che tendono la mano, mentre il padre suona nenie di Natale. Essi, sin dal primo mattino, scen-dono e risalgono nei vagoni fino all’ultima corsa, e riescono a scuotere l’assuefazione dei passeggeri. Nel libro il ricordo del passato è sempre coniugato col presente e animato dal calore della carità, dell’amore per il prossimo, in particolare per i poveri e i diseredati.
Dopo il Natale, viene per i bambini la festa piú attesa e gratificante, la Befana! Essa occupa un grande spazio nel libro e viene descritta in tutti i momenti del sacro rito, con le parole semplici e leggere che si addicono ad una favola. Siamo nel dopoguerra, negli anni 1955-56, e la vecchia bizzarra con il cuore d’oro non ha granché da portare in regalo e le calze appese al camino conten-gono poche, umili cose, ma i bambini sono ugualmente felici: «noi aprivamo nelle nostre mani / spicchi di sole dentro un mandarino.» Il piccolo frutto qui, come nella lirica seguente, che dà il titolo al volume, è visto, goduto dai bambini anche nel suo valore evocativo e simbolico. I suoi piccoli spicchi, oltre a nutrire, confortano nel freddo inverno, perché sono visti come spicchi di sole. Superfluo aggiungere che in Alessandrina il mandarino vuole essere anche uno dei simboli della sua terra sici-liana. Il Comune, in armonia con la sua tradizione de-mocratica, è solidale con le famiglie degli operai. «Arri-vò la befana comunale, / per ogni famiglia, al primo nato, / gonne, pantaloni, scarponcini / e bambole con i nomi dell’Est. / Erano le prime bambole animate / e Ta-tiana camminò verso di me. // L’anno appresso ritornai, / ma presi un paio di scarponcini, / scelta previdente la mia / per quell’inverno straordinario / che volle stabilirsi da noi / per mesi e mesi, / cedendo il passo solo all’estate.» (Tatiana).
Siamo nel nucleo centrale del volume, in cui la poesia si arricchisce maggiormente di un’altra dimensione, quella del documento storico.
Il freddo, lungo inverno del 1956 (simile nei danni a quello del 1929) è ricordato in quasi tutta la letteratura europea, recentemente anche dallo scrittore svizzero Julien Dunilac, nel suo ultimo libro di poesie Cinquante poèmes in do mineur (L’Âge d’Homme, Lausanne, 2013).
Di sfuggita ricordiamo che a Scanno si dovettero in-terrompere le riprese del film di Giuseppe De Santis “Uomini e lupi”, anche se alla troupe e alla popolazione venivano portati soccorsi con gli elicotteri. Alessandrina dedica a quell’interminabile inverno numerose compo-sizioni, e anche se gli occhi della bambina e poi quelli nostalgici dell’autrice non possono sfuggire alle sedu-zioni e alla magia della neve, la realtà affiora netta sotto l’immensa coltre bianca: «E continuò la neve / in fiocchi leggeri, / poi piú fitti, piú grandi / quasi bianchi giganti / dalle lunghe dita inanellate. / […] Si sollevò il selciato / delle strette viuzze, / scomparvero le entrate / delle case fumanti, / si camuffò anche l’angelo / che indicava ai passanti / la direzione del vento.» Ma ecco, nella pagina seguente, la strofa con la nota piú dolente: «Era l’inverno del ‘56 / che si allungò oltre la primavera / come i numeretti incolonnati / dentro le pagine della libretta nera.» La libretta nera era il quaderno dei debiti. Ci fu, è vero, un prodigarsi in aiuti, una gara generosa tra i maggiori partiti politici e tra questi le parrocchie, per alleviare le sofferenze e i disagi dei piú bisognosi, ma le conseguenze di quel terribile inverno si fecero presto sentire per adulti e bambini. Alessandrina lasciò di nuovo San Donato per tornare in Sicilia, altri bambini erano partiti per il Nord Italia, dove erano stati accolti da famiglie di buon cuore, che avevano fatto conoscere la loro disponibilità. Gli adulti ripresero la via dell’emi-grazione per gli Stati Uniti, preclusa però ai comunisti e ai segnalati come tali. Tutto ciò è detto compiutamente nella lirica Partenze: «Con l’estate del ‘56 / giunse per me la partenza, / lasciai il mio piccolo mondo / fatto di neve e di vento / e corsi col fischio del treno / a rag-giungere il sole del Sud. // Prima di me, altri bambini erano partiti / ospiti di famiglie accoglienti / in località italiane del Nord […] / E s’intensificò l’emigrazione, / si andava verso il Nuovo Continente, / dove i paesani si facevano garanti / per vitto, alloggio e lavoro.» Anche suo padre fu spinto a partire, «benché non persuaso, / ma fu sospettato comunista / e rimase dov’era il suo cuore / operaio artigiano come tanti, / categoria detta degli artisti / tutti fieri della loro appartenenza.»
La storia del paese, molto noto già allora per la pas-sione politica e l’antifascismo, diventa un tema impor-tante. Il libro di Alessandrina dimostra come un volume di poesie, ricco di riferimenti concreti, può essere una fonte preziosa per gli storici, e come la letteratura in ge-nere è uno strumento privilegiato per definire il clima di un momento e di un’epoca. Occorre tenere presente che la nostra poetessa è anche appassionata di ricerche sto-riche, in particolare sulla Resistenza e i suoi martiri, cui ha dedicato articoli assai importanti.
Se lo zio di Alessandrina è socialista, il nonno invece è un anarchico, un idealista romantico, nemico di ogni compromesso. La Sinistra sandonatese ne annoverava parecchi (faccio un solo nome, quello di Antonio Quin-tiliani, amico mio e del noto anarchico cassinate avv. Vincenzo Di Mambro, caro ad entrambi, e fratello di Maria, storica bidella della locale Scuola Media). La fi-gura del nonno sandonatese campeggia quasi a chiusu-ra della prima sezione del volume, nella lunga composi-zione intitolata Nonno, di cui riportiamo la prima parte: «Mastro Carmelo, muratore artista / ti chiamavano il mago dei tetti / ma cadendo giú rimanesti zoppo. / Ve-dovo anzitempo / di Alessandrina / (porto il suo nome) / orfano di madre che ancora eri bambino. / […] Into-navi l’inno, nel letto, ogni sera, / era la tua preghiera, / poi spegnevi il lume e ti addormentavi.» Questo nonno che vive solo e come preghiera serale, prima di addor-mentarsi, intona l’inno anarchico, e, per uno strano pudore, è poco loquace con la bambina, che invano gli chiede il racconto di una favola, ci ricorda, per contra-sto, il tenero e affettuoso nonno siciliano Zú Pè, che la notte di Natale è il primo ad accompagnare la nipotina nella chiesa gremita di fedeli.
La prima sezione del volume contiene anche compo-sizioni dedicate alla scuola elementare, le cui prime quattro classi Alessandrina frequenta nel suo paese. Siamo nella prima metà degli anni Cinquanta, le ferite della guerra sono ancora da rimarginare, e i pericoli ancora incombenti: «e i manifesti, alle pareti della scuo-la, / del bambino con le stampelle, mutilato, / che rac-comandavano di non toccare / residui bellici e oggetti sconosciuti.» Il lettore può rendersi conto del lavoro prezioso svolto dagli insegnanti con infinito amore, per proteggere i bambini loro affidati, farli crescere sani fi-sicamente e moralmente, affinché diventino bravi citta-dini. Ho sempre avuto grande stima dei docenti delle scuole elementari, sia per le solide basi che danno al-l’istruzione dei nostri figli, sia per la loro preparazione enciclopedica, per cui li ritengo la vera ossatura cultu-rale e morale del nostro Paese.
La lettura di questo libro di Alessandrina, anche lei insegnante di scuola primaria, mi ha ulteriormente confermato nella mia opinione. La poesia intitolata La scuola riassume efficacemente i valori in essa coltivati: «belli i due libri con le storie vere / poesie alla patria / e ai valorosi eroi del Risorgimento, / chiari gl’insegnamenti / volti a fare di noi / onesti cittadini / […] eravamo bambini appassionati.»
Chiude la sezione una composizione molto significa-tiva. Dopo la 5a elementare e la Media, frequentate a Palermo, avviene il definitivo rientro al paese montano. Ma Palermo rimane sempre nel cuore, diviso tra la montagna e il mare; una dualità che nell’immediato crea disagio e sofferenza, ma col tempo si rivelerà un arricchimento: «E poi il ritornare / ed essere nel con-tempo altrove / […] dualità dell’io, Giano bifronte.»
Nella seconda sezione acquista particolare rilievo la figura del padre Domenico. Un padre col cuore di bam-bino, che ha una bella voce, è un bravo artigiano-pittore. Con versi leggeri e toccanti, si rievocano gli epi-sodi piú salienti della sua vita fino all’anno della scom-parsa. Durante l’infanzia di Alessandrina e dei suoi fra-telli, il padre, dopo una giornata di duro lavoro, trova il tempo di giocare con loro e anche di raccontare le favo-le, mentre sono a letto in attesa del sonno. La domenica, ecco la tavola apparecchiata con intorno i bambini, a ognuno dei quali viene assegnata una piccola manciata di monetine, e poi, recitata la preghiera, tutti svelti a mangiare i maccheroni che attendono fumanti nella zuppiera. È il bellissimo ritratto delle famiglie numerose di una volta, semplici, contente del poco, laboriose, uni-te, felici. E qui come non sottolineare una peculiarità tutta italiana anche in quegli anni? Un artigiano “so-spettato comunista”, nel paese piú rosso della Valle, che prima di mangiare recita e fa recitare la preghiera ai fi-gli, e nel mese di maggio tutti davanti all’altarino, alle-stito in casa, a cantare le lodi alla “Vergine Bianca”, che ascolta compiaciuta gli a solo del capofamiglia.
Nella lirica intitolata La scala viene descritto con or-goglio il lavoro del padre: «Avevi una scala a libro, pe-sante, / la sistemavi nel mezzo della stanza / e su di essa tinteggiavi […] / Sulla testa mettevi un curioso cappello / che facevi con carta di giornale, / mi sembrava una barca capovolta / e tu l’artista che dipingeva il mare. / Del tuo mestiere / gelosamente custodivi / il segreto delle venature / “finto legno” e “finto marmo” le definivi / e l’accostamento dei colori / con cui ottenevi / le piú rare sfumature. / Avevi la mano ferma, l’occhio esperto, / padre, ero orgogliosa di guardarti.» E in un’al-tra lirica afferma: «Sai, io ero felice / le sere in cui rincasavi / profumato di vernice / e con indosso la giacca / un po’ macchiata di biacca.»
Sono versi che mi piace accostare a quelli dell’amico poeta italo-belga Francis Tessa, anche lui fiero di un padre pittore come quello di Alessandrina.
Questi artigiani-artisti, di cui non solo i figli e la fa-miglia, ma l’intera comunità era giustamente orgoglio-sa, in Ciociaria, sono venuti quasi tutti scomparendo, a partire dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, sia a causa dell’emigrazione, sia perché l’istituzione an-che nei piccoli paesi delle scuole di Avviamento, poi tra-sformate in Medie, e la provincializzazione di molte strade comunali, ha trasformato molti di essi in bidelli o cantonieri. Malgrado la grande bravura dell’artigiano, il suo lavoro rimaneva precario e non adeguatamente re-tribuito. La sua fuga all’estero o verso il “posto fisso” va capita e giustificata, tenendo conto anche dell’assenza di politiche di incoraggiamento del suo importante settore produttivo.
Gli anni volano, i genitori invecchiano: «hanno la te-sta bianca / e i segni del tempo / inesorabili sul volto.» Le palpebre appesantite rimpiccioliscono i loro occhi, ma lo sguardo rimane quello di una volta: «severo e pe-netrante» quello della madre, «bambino e sorridente» quello del padre.
La severità dello sguardo della madre, ancora viva, è stata già oggetto di una poesia precedente, Lo specchio, e basta da sola, nell’economia del libro, a farci capire l’arduo compito che la donna ha dovuto svolgere per guidare, accanto al marito, una numerosa famiglia.
L’amatissimo papà riconquista subito la centralità che conosciamo; «I tuoi occhi, padre, / sono racchiusi tra gli anni / e il celeste che prima vi splendeva / sem-bra ormai spento, / cammini curvo, / hai il passo lento. / Io mi domando se ti ho donato amore.» Ecco la do-manda angosciosa che ancora si pone Alessandrina. E la domanda è subito seguita da un tenero proposito: «Il piú è andato, padre, / […] / ma per quanto rimane / sento che riuscirò a recuperare.» Certamente gli affanni degli ultimi anni di Domenico sono stati alleviati anche dalle premure della figlia amorosa. E a vegliarlo nell’ultima notte della vita terrena è Alessandrina, ricavandone, quasi premio alla sua devozione e buona volontà, l’ispirazione per i versi straordinari, che trascriviamo incolonnati come sono nel libro, trattandosi non solo di uno dei vertici poetici del volume, ma anche di alcuni dei piú bei versi ispirati dall’amore filiale per il padre:
27 Febbraio 2005
Mi offrono una sedia
per l’ultima notte al tuo fianco,
ti veglio, ti sfioro la fronte
già madida di sudore.
Padre, nel tuo leggero bagaglio
porterai anche la mia carezza?
La terza sezione si apre con la confessione di una consuetudine e di un rapporto con la poesia, trattata, con incantevole confidenza, come un’amica; «Arrivi / e in quel momento / tralascio il fare / per ascoltarti. / Mi parli / e sento / quel che volevo da tempo.» Ecco la rag-giunta saggezza del giusto equilibrio tra il fare e il con-templare, il meditare, qui simboleggiato dalla poesia! Si arriva, per vie e con parole molto semplici, a un’ul-teriore verità: la poesia, che nella prima sezione era il paese stesso, qui è la fanciullezza. Un’infanzia, cioè, che pascolianamente offre la sua visione del mondo al poeta, e ne riceve in cambio il dono miracoloso di rimanere ferma, fissa per sempre, di diventare foscolia-namente eterna: «Ti accorgi / che il tempo / non infrange / i sogni cullati. / Sorridi, Poesia / sei tu la fanciullezza / che non corre via.»
Il motivo dell’infanzia percorre questa sezione anche con implicazioni meno impegnative, come nei versi: «Nell’urlo del vento / dietro i vetri appannati dal fiato / ritorniamo fanciulli in attesa.»
E compaiono anche due bambini, che ci dicono come, col passare degli anni, sono mutati i ruoli dell’autrice, qui in veste prima di madre e poi di nonna. In Ncencerrò (a Silvia) è Alessandrina che racconta la favola preferita alla figlia bambina: «Ncencerrò era la fiaba / che mi chiedevi / e al finale sempre ti addormentavi […] Io restavo a te vicina / e sfioravo i tuoi riccioli belli, / ascoltavo il tuo respiro tranquillo. / Il cacciatore / anche oggi le aveva salvate / dal pancione del lupo briccone. / Ncencerrò forse ti somigliava, / in punta di piedi me ne andavo.»
Nella poesia che chiude la sezione e l’intero volume Alessandrina si presenta nelle vesti di nonna. Visita An-zio, la città dello sbarco alleato del gennaio 1944, in-sieme al nipote Livio: «Sui muraglioni del porto i tabel-loni / che ricordano la storia / dello sbarco alleato / con case rase al suolo / e gente in fuga. // Guardiamo attentamente insieme, / ti fai piú vicino / mi stringi la mano, / e leggo nei tuoi occhi di bambino / la richiesta di pace e di amore. / Sarai tu a fare il mondo migliore?.» È una poesia impegnata a fare della memoria storica un efficace strumento di pace. Altre ne abbiamo incontrate e vi accenneremo presto, ma prima vogliamo ricordare la compresenza anche nella sezione di altri importanti motivi.
Nella penultima lirica Ma Tu ci sei, ci viene ricordato come la pace e la fratellanza tra gli uomini trovano nel sacrificio di Cristo un fondamento religioso, ispirato alla Carità, cui si ricorre sempre trovandovi il conforto piú grande e durevole: «Nella Tua Croce / che l’umanità raccoglie / come granulo di sabbia d’oro / io mi ritrovo / e in Te, Sapienza e Amore, / respiro pace e la diffondo intorno.»
Tornano nella sezione i rapporti tra gli elementi na-turali, che caratterizzano piú marcatamente il paese montano e l’uomo. Nella poesia Tramontana si mettono in rilievo sia le case del borgo che strette l’una all’altra possono resistere meglio alla sua forza (un chiaro rife-rimento alla necessità di unirci per essere forti contro nemici e avversità), sia la naturale barriera delle piante di ulivo, di cui però il vento disperde i frutti, sia infine la tenace pazienza dell’uomo che si china a raccoglierli: «Sotto l’aria cruda e pungente, / con pazienza e fatica, / li raccoglieranno ad uno ad uno, / annosa sfida tra la natura e l’uomo.»
In un’altra lirica, tra le piú belle dell’intero volume, Rosa d’autunno, si descrivono con grazia e tenerezza due doni della natura, il fiore e la «stagione che non vuole finire»; ma appare anche con grande evidenza un’altra caratteristica fondamentale di ogni poeta e artista in generale: lo stupore e la gioia che avverte piú degli altri davanti alle bellezze apparentemente minori del creato.
Sul piano dell’impegno e della memoria storica spic-ca il rendiconto in versi di un viaggio in Polonia con un gruppo di insegnanti di vari Paesi europei. La suite è in crescendo e termina con la composizione dedicata alla visita al campo di sterminio di Auschwitz: «Varchiamo il cancello di Auschwitz, / ci aggiriamo tra i blocchi / che tracciano i viali del campo, / nella piazza dell’appello, / intorno all’albero dell’impiccagione. / Incombe un cielo d’acciaio / arrugginito come le rotaie / che traducevano dentro le baracche, / lasciando a mezz’aria / i pallidi, minuscoli biglietti / che imploravano un ultimo contatto / col mondo che rimaneva fuori. // Entriamo nel museo degli effetti personali: / dietro le vetrate, montagne di oggetti / che sprofondano nel ventre della morte, / ed è tanto il vestiario dei bambini.» Tornando in albergo, vedono ai margini della strada «un contadino / con un cesto di mele rosse, / una sfida ai fantasmi della sera», ed un’ulteriore allegoria, aggiungiamo noi, dei doni della natura che risarciscono la vita umana delle follie omicide e suicide dell’uomo stesso. In questo caso, della follia nazista, di Hitler, il piú sanguinario tiranno di tutti i tempi.
Alessandrina De Rubeis ha saputo armonizzare le due identità, quella siciliana e quella ciociara, di cui si compone la sua personalità, allargando l’ambito dei suoi interessi e il suo orizzonte culturale oltre i confini della provincia, dando cosí maggiore profondità e rilevanza alla sua opera poetica e alla sua ricerca storica.
Le illustrazioni sottolineano, con discrezione ma con sincera adesione e consonanza, i motivi piú importanti del volume, e ne rendono piú evocativa e toccante l’at-mosfera. Molto felici per la tecnica raffinata i disegni di Marco Coletti; pregevolissime le foto di Mario Piselli (insegnante assai noto anche per l’alto livello dei suoi scatti), dello Studio fotografico Marini, e di Tonino Ber-nardelli.
Gallinaro, 3 dicembre 2014
Gerardo Vacana